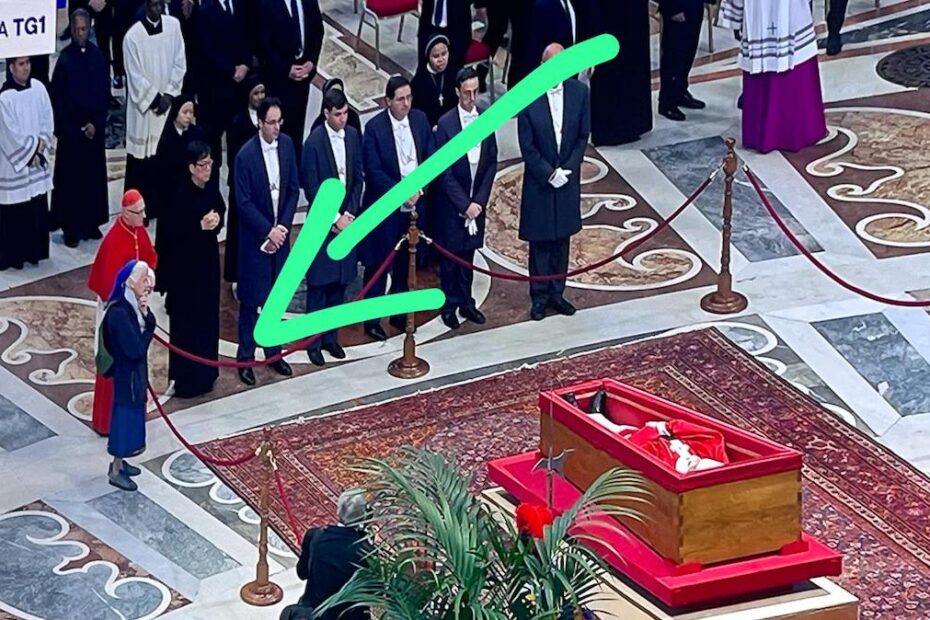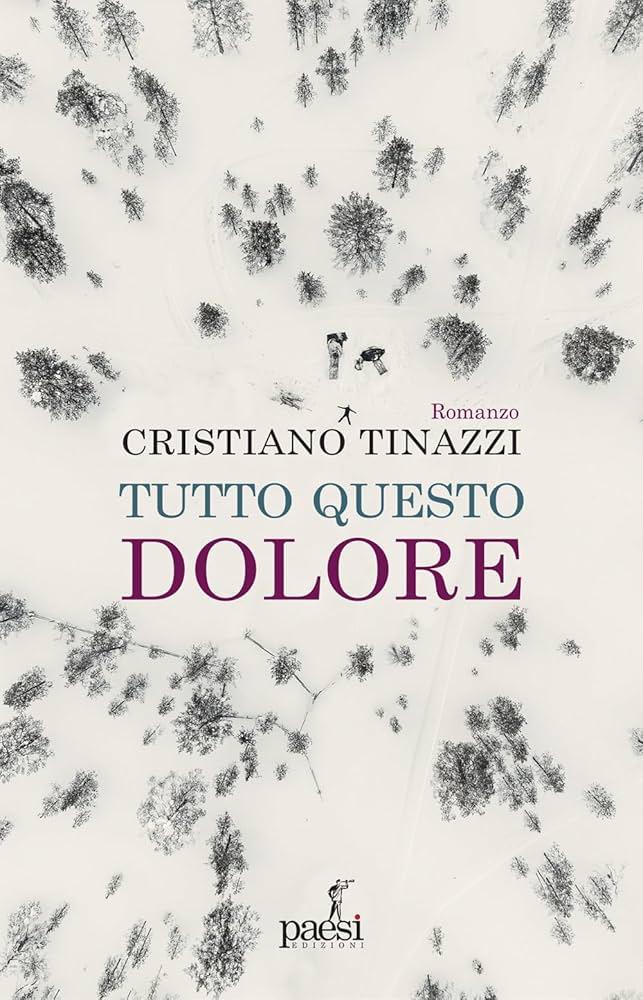
Il conflitto tra Russia e Ucraina è stato raccontato, analizzato, discusso con toni spesso distanti dalla realtà vissuta. Eppure, dietro ogni cronaca, ogni mappa strategica, ogni talk televisivo, si muovono le storie delle persone, i traumi invisibili, le ferite che non fanno notizia. Questa guerra – iniziata ben prima del febbraio 2022 – ha smascherato l’incapacità dell’Occidente di leggere la violenza per ciò che è: un atto che non solo devasta le città ma disgrega l’identità, consuma i legami, paralizza la memoria. In un’epoca in cui la propaganda si traveste da informazione e la neutralità diventa comoda abdicazione, è sempre più difficile trovare una voce che si assuma il rischio di sentire ciò che racconta. Cristiano Tinazzi lo fa. Con coraggio, con pudore, con verità.
Tutto questo dolore è molto più di un reportage: è un viaggio verticale dentro la guerra e dentro di sé. Tinazzi scrive da giornalista ma anche da uomo attraversato dalla sofferenza, restituendoci un racconto che mescola campo e coscienza, testimonianza e autobiografia. L’Ucraina non è solo il luogo dell’invasione russa, ma il punto d’incontro tra l’orrore della storia e le fratture dell’anima. Nei suoi viaggi tra Dnipro, Severodonetsk, Kharkiv, il giornalista incontra soldati, volontari, civili, donne in armi e uomini spezzati, ma soprattutto riconosce in ciascuno un frammento del proprio dolore. Le esperienze raccolte lungo il fronte diventano allora un pretesto per guardarsi dentro, affrontare i lutti non elaborati, la depressione, la fatica del vivere. E così il trauma diventa racconto, e il racconto si fa forma di cura.
Tinazzi non cerca eroi e non si propone come tale. Al contrario, si mostra nella sua imperfezione, nella sua fatica di stare al mondo senza una guerra che giustifichi la tensione costante. Riflette sul mestiere del reporter, sulla “giusta distanza” che protegge ma anestetizza, e racconta la psicanalisi come campo di battaglia parallelo. Il dolore, ci dice, va ascoltato, nominato, condiviso. E in questo processo, scrivere diventa atto politico e terapeutico, una forma di resistenza alla disumanizzazione.
Non mancano nel libro passaggi di grande intensità civile: la denuncia della disinformazione filorussa penetrata anche nel giornalismo italiano, l’ambiguità di un certo antiamericanismo strisciante, la necessità di prendere posizione senza infingimenti. Ma tutto questo non è espresso con ideologia: emerge dal campo, dalle voci incontrate, dalle storie raccolte. Tinazzi non costruisce teorie: mette in scena la verità, la osserva, la ascolta, la accompagna.
Tutto questo dolore è un libro che resta. Perché non pretende di spiegare, ma riesce a farci sentire il peso di ciò che la guerra lascia dentro. È una ferita aperta, ma anche un luogo di consapevolezza. È un grido sommesso che si fa memoria condivisa. E in un tempo che dimentica in fretta, questo è forse il gesto più importante che un libro possa compiere.